Il Trattato di storia delle religioni di Mircea Eliade, storico delle religioni, filosofo ed orientalista romeno, si erge come una magna opera di architettura intellettuale, che non si limita a disegnare il volto delle religioni ma ne penetra le viscere, esplorando il Sacro come una forza universale che, come un invisibile filo d’oro, tesse il destino dell’uomo e dell’universo stesso. Il Sacro, per Eliade, non è una mera costruzione sociale, un mero abito ideologico cucito dalle tradizioni; è un’entità ontologica, un principio primordiale che si riversa nel fiume della Storia e nel cuore della coscienza umana.
La sua proposta è individuare le strutture archetipiche del pensiero religioso attraverso un’analisi fenomenologica che integra elementi storici, antropologici e filosofici. Il Sacro, distinto dal profano, viene definito come una categoria della mente che si manifesta nella realtà attraverso hierophanie, fenomeni che rendono il mondo intelligibile e carico di significato per l’uomo.
In tal senso, Eliade si distacca dal riduzionismo positivista o psicologista, proponendo una visione secondo cui la religione è un’esperienza originaria ed universale che fonda la comprensione del cosmo e della vita. Da qui, l’enfasi posta sui simboli, sui riti e sui miti come linguaggi del sacro, da non reputarsi quali banali ornamenti culturali, ma strumenti epistemologici che veicolano verità esistenziali e cosmologiche. Simboli come l’albero, la montagna o il centro del mondo, lungi dall’essere pretti segni, sono condensati di significati universali che collegano l’umano al trascendente. Come lui stesso afferma, «il sacro non è una mera costruzione culturale, ma una dimensione ontologica, una presenza che accompagna l’uomo fin dalle sue origini» (Trattato, p. 12). In quest’ottica, la religione, distante da una serie di credenze e riti, è un linguaggio sacro che consente di conversare con l’Infinito, una modalità privilegiata per attraversare l’orizzonte del visibile e fare esperienza di una realtà che trascende la banalità dell’esistenza quotidiana: «Una modalità di accesso al reale, un linguaggio simbolico che permette all’uomo di dialogare con l’infinito» (ivi, p. 27).
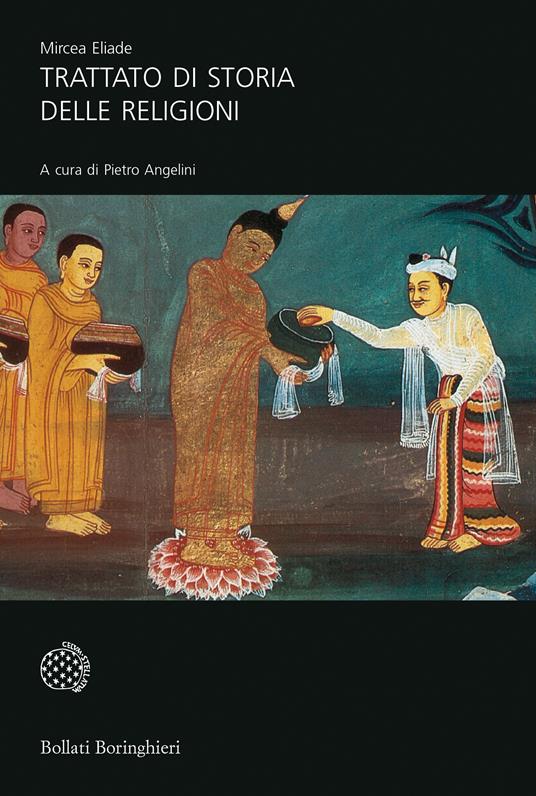
La concezione eliadeana del Sacro si discosta in maniera netta dalla prospettiva di Émile Durkheim, che vedeva nella religione un fenomeno di coesione sociale, un collante che legava le società primitive. Durkheim, nel suo Le forme elementari della vita religiosa, analizzava la religione come il prodotto di una necessità sociale di sacralizzare la vita comune, ma, per Eliade, la religione è un’eco di un principio cosmico che non ha bisogno della società per esistere. Se per Durkheim il Sacro trova la sua origine nell’umanità che lo costruisce come strumento di coesione, per Eliade esso è un principio preesistente, una radice che precede e fonda il sociale. «Il mito non è un racconto del passato, ma una realtà che ritorna eternamente» (ivi, p. 179). Quest’affermazione suggerisce che il mito non è un racconto che si esaurisce nell’aneddoto, bensì una forza che rivive continuamente, rinascendo nel rito e nel gesto sacro, che ricreano il mondo e ripristinano l’ordine cosmico.
Il rito, in questa ottica, non è mai una semplice ripetizione meccanica. Ogni gesto rituale è un ritorno al tempo primordiale, un viaggio nell’eterno che rinnova la realtà. Come Eliade scrive, «ogni atto rituale non è una semplice ripetizione, ma una partecipazione diretta al cosmo che si rinnova» (ivi, p. 87). Il rito diventa, così, la porta attraverso cui l’uomo varca la soglia dell’ordinario per entrare in contatto con l’originario. Il sacrificio e il mito si fondono in un movimento ciclico che riorienta l’uomo verso il cuore del cosmo, come nel mito di Osiride, la cui morte e rinascita non sono meri eventi cosmici, ma archetipi eterni che rispecchiano il ciclo perenne di vita e morte. Il rito che celebra Osiride è, sì, un atto di venerazione verso il dio, ma anche una riscrittura della realtà, una restaurazione dell’ordine cosmico che coinvolge tutta la comunità e la riporta alla sorgente originaria.
Questa visione del Sacro come forza strutturante della realtà, tuttavia, non si limita alle religioni antiche. In effetti, Eliade scrive un capitolo di straordinaria finezza sulla religiosità cristiana, interpretandola come una sintesi perfetta tra il Sacro ed il profano, in cui l’Incarnazione rappresenta la congiunzione tra il divino e l’umano, l’eterno ed il temporale, «il punto focale in cui l’eterno si incarna nella storia» (ivi, p. 310). L’Incarnazione, pertanto, è un evento storico che segna una cesura con le religioni politeiste e, al contempo, «un modello eterno che rinnova il rapporto tra l’uomo e Dio» (ivi, p. 312), come se la materia stessa si piegasse per ricevere la luce del divino e trasformarla in un nuovo ordine di significato. Eliade vede nel Cristianesimo non una rottura rispetto alla sacralità delle religioni antiche, ma una sua trasfigurazione che conserva l’essenza della sacralità arcaica, proiettandola in una dimensione universale e storica.
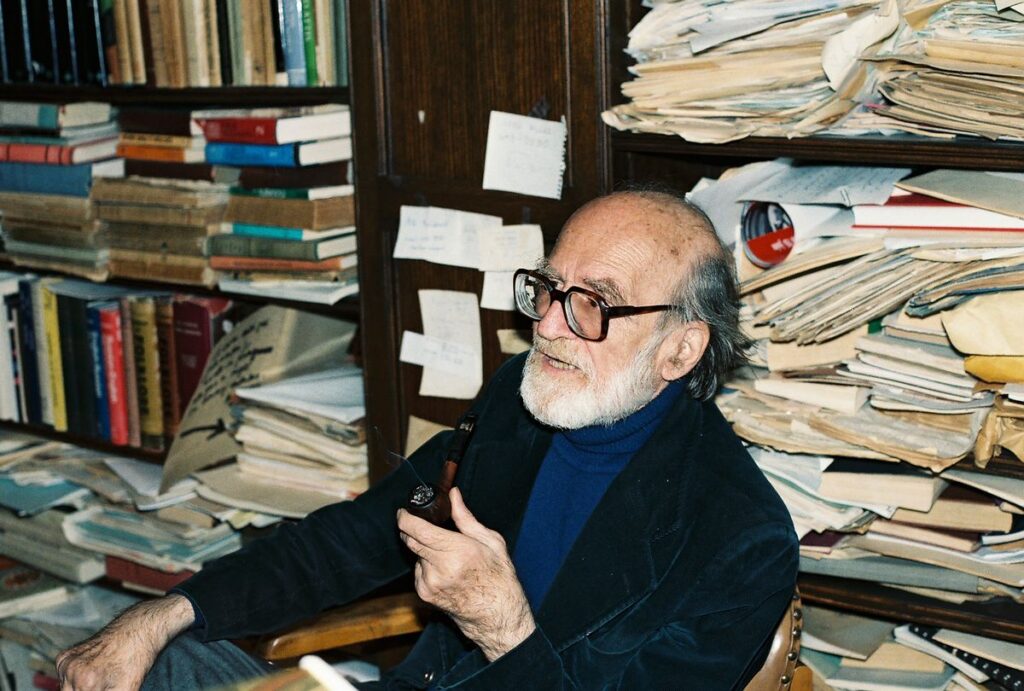
Nell’analisi della modernità, il pensiero di Eliade incontra quello di altri studiosi della secolarizzazione come Charles Taylor, che, nel suo La secolarizzazione, riflette sul vuoto di sacro che pervade la vita contemporanea. La modernità, con la sua incessante razionalizzazione del mondo, ha privato l’uomo del contatto diretto con il Sacro, relegandolo nel regno dell’immanenza, ma Eliade non vede questa condizione come un esito inevitabile: «La grande tragedia del mondo contemporaneo risiede nella sua incapacità di percepire il sacro» (ivi, p. 212). Il progresso ha liberato l’uomo dalle superstizioni ed ha anche svuotato la realtà di ogni significato profondo, riducendo l’esistenza umana ad un gioco di forze meccaniche e materiali. La scienza, pur essendo una straordinaria conquista, «non può sostituire la funzione del sacro, che risponde a un bisogno profondo e strutturale dell’anima umana» (ivi, p. 214). La secolarizzazione ha ridotto la realtà ad un insieme di fenomeni disincantati; ciononostante, la riscoperta del sacro non è una nostalgia del passato, ma una necessità per ridare profondità alla vita moderna: «La sacralità non è un retaggio obsoleto, ma una realtà viva che l’uomo deve imparare a riconoscere» (ivi, p. 278). Non un ritorno al passato, ma una riscoperta dei simboli e dei miti che ancora oggi custodiscono la scintilla del divino.
Così, Eliade invita a riscoprire la sacralità nella modernità, a riannodare il filo che ci lega al cosmo ed al divino. La sua proposta non è un incitamento a disconoscere la razionalità scientifica, ma ad integrare in essa una visione che veda l’uomo come parte di un ordine cosmico eterno, dove ogni gesto ed ogni parola partecipano ad un disegno più grande: «Ogni mito, ogni rito, ogni tradizione religiosa contiene una scintilla del divino, che attende di essere riscoperta» (ivi, p. 280). In quest’ottica, il ritorno al sacro diventa un’opera di ri-creazione del mondo, una rifondazione che ridà significato all’esistenza e che restituisce all’uomo la consapevolezza della sua connessione con il divino. In questo mondo disincantato, la riscoperta del Sacro non è solo un ritorno, ma una via per un nuovo inizio, una forma di redenzione che potrebbe riempire il vuoto che il presente ha lasciato nel cuore dell’uomo: «Solo riscoprendo il sacro, l’uomo potrà ritrovare il senso profondo della sua esistenza e riconciliarsi con l’universo» (ivi, p. 310). In tale prospettiva, il pensiero di Eliade stimola a riscoprire il nostro posto nel cosmo ed a percepirci come partecipi di una realtà che trascende la mera apparenza, dove ogni gesto umano, ogni parola, ogni pensiero diventano specchi di un ordine divino eterno.